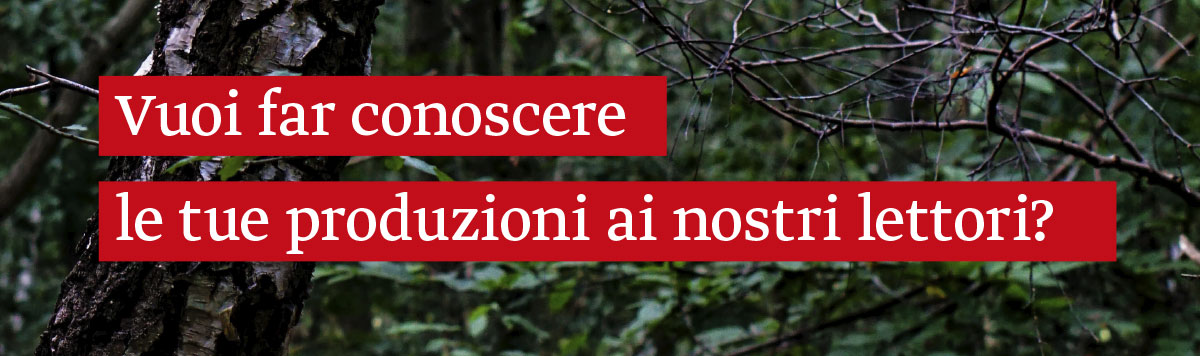CRITTURA. Racconta il mondo contemporaneo attraverso romanzi-saggio e romanzi “puri”. L’importanza della consapevolezza letteraria, i “libroidi”, l’eccessiva produzione nel settore editoriale e i fuorvianti criteri dell’ISTAT nel fotografarla. La precarietà degli scrittori? Una “scelta”. Quella dei lavoratori editoriali? «Devastante».

Vanni Santoni è uno dei protagonisti più eclettici della letteratura italiana degli ultimi tempi: in vent’anni ha scritto e pubblicato romanzi e racconti di più generi, cui ha affiancato raccolte di epigrammi, romanzi scritti a più mani e avventure poetiche. La sua produzione vasta ed eterogenea ha accompagnato l’attività da giornalista culturale, che lo vede tuttora collaboratore di Linus, La Lettura del Corriere della Sera e del Corriere fiorentino, qualcosa per cui “finisco quindi per porre l’attenzione su dodici libri ogni mese”, recensendoli. Dal 2014 al 2021 ha diretto la sezione narrativa di Tunuè.
Lo abbiamo incontrato per capire come nasce uno scrittore della letteratura italiana del 2000, un processo più utile che mai per raccontare e analizzare il complesso mondo contemporaneo.
Il tuo ultimo romanzo Il detective sonnambulo vede personaggi legati al mondo delle criptovalute e delle blockchain, fenomeni che hanno un po’ perso d’attualità. Se penso a tue opere precedenti e pur diversissime, come Muro di casse e Dilaga ovunque, mi sembra ci sia un tuo sguardo ricorrente su fenomeni e sottoculture in crisi. C’è un filo conduttore programmato tra le tue opere?
In molti nella mia bibliografia vedono due filoni: da una parte i romanzi-saggio e dall’altra i romanzi “puri”. I primi – i due che citi più La stanza profonda – sono usciti tutti per Laterza, i secondi per Mondadori (a parte Gli interessi in comune, che era uscito per Feltrinelli). In fondo c’è del vero in questa distinzione, sebbene i due filoni si mescolino più di quanto non sembri. I romanzi-saggio contribuiscono alla continuità narrativa di tutti gli altri libri in maniera decisiva. Ad esempio, uno dei tre protagonisti di Muro di casse, Iacopo Gori, viene dal mio primo romanzo Gli interessi in comune; un altro, Cleopatra Mancini, nasceva come personaggio-funzione, per inserire nel testo riflessioni prese da saggi sulla cultura rave, che la stampa ha spesso mistificato, mentre la sociologia ne ha parlato in maniera approfondita. Quando ho deciso di scrivere un libro sul misticismo, Cleopatra Mancini si è qualificata come una potenziale protagonista in qualità di sociologa marxista e atea, prodotto del materialismo storico. Tutto questo rendeva molto complicato, e quindi narrativamente interessante, il percorso che una persona del genere avrebbe dovuto fare per diventare una grande mistica Questo è solo uno dei tanti esempi utili a dimostrare come la mia produzione ibrida si leghi a quella romanzesca in più occasioni. Un altro esempio recente: Cristiana Michelangelo, una dei cinque protagonisti dei Fratelli Michelangelo, diventa poi la voce narrante di Dilaga Ovunque.
In generale, il romanzo è sempre uno strumento di analisi della società, contiene già, insomma, il saggio - al pieno dei suoi poteri. Già da fine Ottocento, ancor di più col romanzo novecentesco (penso ad esempio a L’uomo senza qualità di Musil), il grande romanzo è sempre stato un contenitore di digressioni saggistiche.
In Il detective sonnambulo ho cercato di trattare le criptovalute con consapevolezza e il personaggio di Manfredi Contini della Torre è lo specchio di quattro criptomilionari reali che ho potuto intervistare via Telegram. Oltre a loro, ho studiato molti altri materiali a tema trovati in rete, ma se lo devo utilizzare in un romanzo, ritengo fondamentale approfondire un fenomeno anche di persona. Questo lavoro mi ha permesso di perseguire un certo realismo con Manfredi, e di essere credibile quando ho parlato di criptovalute. Quando un romanzo tocca un certo tema, le cose che si dicono su di esso devono suonare verosimili, anche se al lettore magari non interessano, perché da ciò dipende la credibilità di tutto il testo. Per fare un esempio, in Pastorale americana Philip Roth ha descritto minuziosamente le procedure di produzione dei guanti, poiché il protagonista è il figlio di un piccolo industriale del settore. Questa minuzia è sì utile per raccontare il passaggio dall’artigianato all’imprenditoria di una certa fascia della popolazione di Newark, ma è stato inserito con tanta precisione anche per dare credibilità al racconto nel suo complesso.
Tornando al mio libro, ammetto di non aver pensato dall’inizio di parlare di criptovalute. Ero certo di volerlo ambientare nell’ipercontemporaneo e di parlare delle disuguaglianze in aumento tra ricchi e poveri, ma è venuto fuori prima l’intreccio del quadrilatero sentimentale: “Lui, lei, l’altra e… il ricco che viene a rompere le uova nel paniere”. Potrebbe essere la sinossi di una commedia di Molière o di Goldoni o una messa in scena della Commedia dell’Arte… A quel punto c’era da decidere che tipo di ricco sarebbe stato il nostro Manfredi. In Italia al più un ventitreenne un patrimonio così grande lo eredita, non lo guadagna. Alla fine la scelta è caduta sulle criptovalute, perché portavano realismo, contemporaneità e pure una certa “assenza di merito” nella biografia di Manfredi, come molti criptomilionari diventati ricchi senza volerlo. C’è poi la natura estremamente impalpabile delle criptovalute: adeguata, visto che siamo oggi in una società più che liquida, gassosa, che ha reso il denaro etereo, invisibile (ma con questo più controllabile)… Insomma, ci stava.
(...)