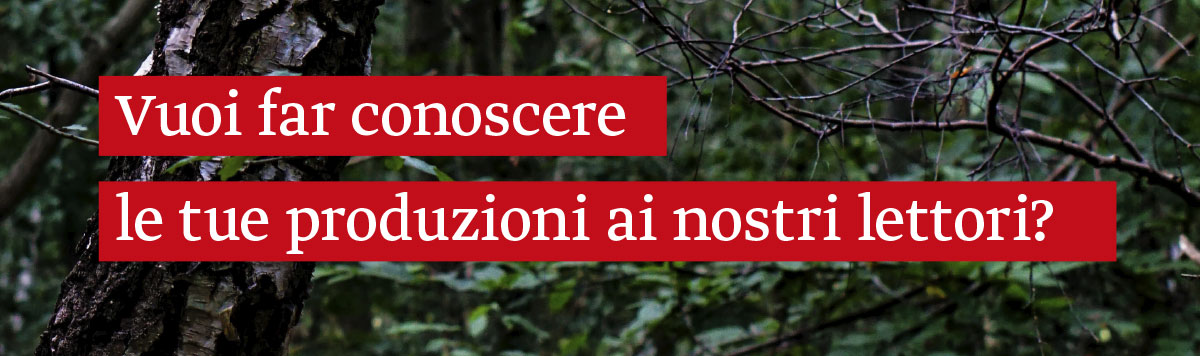Dagli anni Settanta fotografa i popoli e i movimenti in lotta per i diritti in Italia e nel mondo. Nei libri accompagna le foto con scritti spesso urticanti «Non ho mai amato la fotografia che documenta. La fotografia che mostra il mondo com’è. La fotografia che non altera i rapporti di forza orribili che reggono il mondo». Gli abbiamo chiesto chi sono i soddisfatti «Sono quelli a cui va bene il mondo come è, hanno avuto tutto quello che volevano e si sentono completi, soddisfatti di sé stessi. La soddisfazione porta a non fare niente per cambiare lo stato delle cose».

Tano D’Amico in un ritratto di Dino Ignani
Nato nel 1942 a Filicudi, cresciuto a Milano, romano di adozione, Tano D’Amico negli anni ha collaborato con quasi tutta la galassia dei giornali e delle riviste della sinistra, dai più moderati, come Repubblica, ai più militanti, come Lotta Continua e Potere Operaio, passando per il Manifesto e Ombre Rosse. Molte delle sue immagini sono nel tempo divenute vere e proprie icone nell’immaginario visivo italiano, soprattutto nell’ambito movimentista; ogni qual volta si parla del ‘77 è molto probabile che ad accompagnare le parole ci siano le sue foto. Ma i suoi reportage hanno raccontato anche l’Italia dei decenni successivi, la Palestina, la Grecia, l’Irlanda, la Germania, la Svizzera, la Spagna e il Portogallo. I suoi tanti libri sono spesso accompagnati da riflessioni sulla professione, sul linguaggio fotografico e sullo stato delle cose con una attitudine ferocemente avversa a coloro che D’Amico chiama i soddisfatti. Le sue parole sanno essere urticanti, per nulla concilianti, valga come esempio il testo Odio le foto belle contenuto in Di cosa sono fatti i ricordi (Postcart, 2011):
«Non ho mai amato le fotografie di intrattenimento. Non ho mai amato le fotografie da appendere al muro, le fotografie che servono a compiacere, le fotografie che lasciano le cose come stanno. Non ho mai amato la fotografia che documenta. La fotografia che mostra il mondo com’è. La fotografia da prova a carico o a discarico. La fotografia che non altera i rapporti di forza orribili che reggono il mondo. È la cosa più reazionaria che ci possa essere. Ho sempre amato la fotografia che va al di là della realtà. Al di là della realtà così come appare. Amo la fotografia che riesce a mostrare anche quello che non si vede. Quella che riesce a vedere le speranze delle persone rappresentate. E se non ci sono, se c’è solo la disperazione nell’umanità che mostra, faccia partecipare le speranze del fotografo. La sete che lo ha spinto per strada. Non ho mai amato le fotografie che sembrano così belle da poter fare a meno dello spettatore. Che condannano lo spettatore a un ruolo inutile e passivo. Che sembrano così belle da reggersi da sole davanti agli occhi degli spettatori. Sono nate già morte. Le più note sono degli inutili idoli morti. Idoli che puntellano realtà statiche. Le cementificano, le rapprendono per sempre. Amo la fotografia che richiede la partecipazione dello spettatore. Ne ha bisogno. Che chiama lo spettatore a dare giudizi sulla realtà che sta vivendo. Che chiama lo spettatore a un ruolo attivo di essere umano. Amo la fotografia che aiuta a vivere, che tiene compagnia. Amo la fotografia che non serve niente e nessuno. Che ha vita e dignità propria. Che non serve a niente. Come l’amicizia e l’amore».
Quando ha sentito di essere padrone del linguaggio fotografico?
Forse non lo sono nemmeno ora. Questo senso di soddisfazione non l’ho mai avuto e spero di non averlo mai. Nella Bibbia il sarcasmo dei soddisfatti è descritto come qualcosa di orribile. Ecco, io penso che anche i soddisfatti siano un po’ orribili.
Questo nel lavoro, ma più in generale, i soddisfatti chi sono? Perché è un termine che torna spesso nelle sue interviste e nei suoi libri.
I soddisfatti sono quelli a cui va bene il mondo come è, hanno avuto tutto quello che volevano e si sentono completi, soddisfatti di sé stessi. La soddisfazione porta a non fare niente per cambiare lo stato delle cose. Sentirsi soddisfatti è qualcosa di statico, è il non curarsi delle persone che stanno peggio.
Dal punto di vista professionale, del lavoro, del portare a casa lo stipendio, come sono stati tutti questi anni?
Non ho mai portato a casa stipendi. Sono stato sempre indipendente. Se mi andava bene prendevo un tanto a foto. Penso di essere stato fortunato perché ai miei inizi c’era una sete di immagini diverse che poi è scomparsa. Venivo accettato per la diversità delle mie immagini. Sia nella stampa nostra, quella di movimento, sia in certa grande stampa che è scomparsa. Penso al Messaggero degli ultimi anni Sessanta e dei primi Settanta: aveva una grafica bellissima e per le immagini era competitivo con qualsiasi altro giornale; oltre ad avere i suoi dodici bravi fotografi assunti che lavoravano 24 ore su 24 divisi in tre turni — una cosa impensabile oggi — diverse volte ha pubblicato le mie foto. C’era un padrone, Alessandro Maria Perrone, che con un sarcasmo amaro si vantava di non aver mai lavorato fino a cinquant’anni, aveva giocato a tennis fino a quando il maggiordomo non gli aveva comunicato che non gli mandavano più la spesa a casa per la cena. Della grande fortuna dei Perrone (erano stati i proprietari del gruppo industriale Ansaldo, Ndr) era rimasto solo un piccolo giornale a Genova, Il Secolo XIX, e un piccolo giornale a Roma, perché all’epoca il Messaggero era un piccolo giornale. Da quella notte andò a dormire in redazione. Coinvolse i giornalisti più brillanti che aveva incontrato nella sua vita e loro lo aiutarono a fare un bellissimo giornale che sostenne le grandi battaglie civili, come quelle per il divorzio e per i diritti delle donne, mentre tutti i partiti erano contro. Quando si vinceva un referendum il popolo romano non andava sotto le sedi dei partiti, andava sotto quella del Messaggero per ringraziare e i giornalisti e i tipografi gettavano coriandoli dalle finestre. In quegli anni l’Europa era molto diversa, la Grecia era preda di una dittatura bestiale, come la Spagna e il Portogallo. Per quei paesi il Messaggero stampava copie su carta molto leggera, senza la pubblicità e senza la cronaca romana perché viaggiavano in aereo per arrivare a Madrid, Barcellona, Atene nelle prime ore del pomeriggio. Per molti colleghi internazionali il Messaggero era il prototipo del giornale europeo. Ricordo quando portai in redazione le foto degli studenti di Atene che manifestavano sul tetto dell’università. Diedero loro molto spazio e un titolo bellissimo, Gli alunni della speranza.
Erano gli anni in cui c’era Piergiorgio Maoloni a disegnare il quotidiano.
Sì, era bravissimo. Fu l’unico a valorizzare le mie foto strette e lunghe che mi piacciono tutt’ora, quelle in cui capitano tante cose, compaiono tanti volti sulla stessa linea. Lui le metteva nel paginone culturale, da un margine all’altro.
Quando ha cominciato a scrivere di sua mano le didascalie, la data e la firma sul fronte delle foto?
Prima le scrivevo o timbravo dietro, ma mi dicevano tutti che nella fretta non le vedevano.
Come si arriva a decidere di esprimersi attraverso le fotografie e non attraverso, che so, le parole o qualsiasi altro linguaggio?
Un suo collega ha scritto: «Se Tano avesse detto con le parole quello che ha detto con le immagini, sarebbe finito in carcere o, nella migliore delle ipotesi, in manicomio».
Ma questo cosa significa, che le immagini sono più o meno forti delle parole?
Non c’è un criterio. Io amo molto le parole dei poeti, che sono come immagini sonore, perché uno anche se legge soltanto con i suoi occhi sente il suono. E anche nelle immagini si può sentire il suono. Ma non tutte le immagini o tutte le parole sono così. Ci vuole molto lavoro. E per lavoro intendo vivere, guardare, subire, opporsi... tutto.
C’è un aspetto che ritorna più volte nei suoi libri, quello del fare le foto da dentro o da spettatore, da esterno rispetto alle cose che accadono.
Penso che siano i personaggi, gli avvenimenti che possono richiedere una cura diversa, l’interno e l’esterno si confondono molto spesso. Ci si deve allontanare se si vuole avere una visione più completa, ma se si vuole interpretare il senso di quello che si vede, si deve anche essere dentro.
Lei si sentiva in sintonia con quello che stava succedendo quando ha iniziato a lavorare con i movimenti?
Mi sentivo in sintonia nel percepire che quella strada non era mai stata percorsa, questo sì.
Nel tempo questa sensazione di sintonia è continuata o a un certo punto si è interrotta?
Se si è interrotta non è stato per volontà mia ma perché quel flusso si è interrotto. A volte si scopre dopo che si è combattuto per la vita e per le immagini, pensiamo alla Repubblica di Weimar, alle grandi battaglie di strada. Chi pensava allora che si stava combattendo per le immagini? Lo pensava la grande industria tedesca che ha prodotto le macchine per lasciare ricordi di quelle battaglie, quando hanno speso somme enormi nella ricerca per arrivare a realizzare macchine fotografiche così piccole da stare in tasca, che potessero funzionare con gli scampoli della pellicola del cinema. Noi abbiamo dimenticato quella battaglia e abbiamo dimenticato anche perché combattevano per la vita delle immagini. Goebbels voleva togliere di mezzo tutte le immagini con un’anima, quelle che io chiamo immagini vive, e lasciare solo le immagini morte, quelle che non hanno alcuna astrattezza, quelle che per Barthes non vanno al di là delle parole. Goebbels diceva «Fate vedere tutto», ma non si doveva andare al di là della lettera, al di là del senso letterale. Anche oggi, vale per Gaza, per l’Ucraina, per tutti i conflitti armati, fanno vedere tutto, ma quasi nessuna immagine è capace di fare memoria, di fare riflettere. Riducono a normalità il genocidio, il massacro. Hanno una funzione orribile, quella di spegnere invece di accendere la partecipazione.
Non pensa che sia anche dovuto alla sovrabbondanza di immagini?
Questa è un luogo comune che non mi ha convinto mai. Se andiamo in stazione a prendere un amico o un’amica, anche se c’è tantissima gente vediamo benissimo l’amico, la fidanzata e così è per le immagini. Se noi aspettiamo una bella immagine, la vediamo.
Che cos’è una bella fotografia?
È difficile dirlo ma si vede subito: è una immagine in cui c’è tutto, c’è il prima e il dopo. C’è anche il contesto, quello che non si vede ma sappiamo. Cito un pittore bizantino di icone: un’immagine che vale per quello che di visibile c’è in essa è ben poca cosa. E l’invisibile che cos’è? è il contesto che non compare. Un’immagine bella è capace di farlo comparire, il ricordo di quello che è successo prima, le speranze per il futuro... quando i compagni sceglievano le mie immagini dicevano «Sei tu che mostri le nostre speranze». La speranza appartiene all’invisibile, come il contesto. Siamo noi che dobbiamo cercare, il prima, il dopo, la storia. Quello che oggi si vorrebbe togliere, come vorrebbero gli storici che scrivono saggi sull’elogio dell’oblìo. Le belle immagini sono invece un elogio della memoria.
Quanto è importante la capacità di leggere le immagini?
Se c’è bene, ma se un’immagine non si fa leggere porta in sé il limite. Una bella immagine penso che sia come un sentimento, non bisogna andare a scuola per averlo, o si ha o no. Una immagine che piace solo ai propri amici, alla propria parte è ben poca cosa. Una bella immagine — in modo esplicito o implicito, lo possono ammettere o no — deve piacere a tutti. Deve farsi ricordare da tutti, anche se in un modo diverso. Siamo abituati a pensare che un’immagine cambi di senso a seconda delle parole che le vengono messe accanto. Vuol dire che è un’immagine superflua, inutile, è un semplice ornamento della parola scritta. L’immagine per come l’intendo io, ci puoi scrivere sei romanzi prima e otto dopo, è lei che si mangia i romanzi.
Qual è il limite fra l’estetizzazione di un’immagine e un’immagine veramente bella?
Per fare una bella immagine e per fare in modo che venga capita occorre studio, non è una cosa spontanea, può anche esserlo. Ci sono colleghi che mi dicono che quello che sostengo me lo potevo permettere perché avevo tempo per pensare il lavoro, per elaborarlo. Non è vero, o meglio è vero che il lavoro va fatto ma si può farlo prima, studiando: uno riesce a trovare la propria immagine, in quel flusso di immagini, in quella cascata di immagini che è un avvenimento se ce l’ha già in mente, se sa dove cercare, in quale momento cercare.
C’è un suo lavoro a cui è più legato?
Non amo molto le mie immagini perché sono esattamente come sono io e trovo che un essere umano che si ami... Amo le immagini che mi hanno portato per mano a essere come sono, amo le immagini dei maestri di tutti i tempi che mi hanno portato a pensare, riflettere; amo soprattutto quelle che mi hanno aperto delle finestre.
In passato ha citato Giovanni Bellini.
Lo amo molto perché dalle sue immagini si vede che che ha toccato la morte e ne è venuto fuori con la bellezza. A lungo ha realizzato immagini di genere, un po’ vuote, scolastiche, poi a un certo punto — pensiamo alla Pietà conservata a Brera — deve aver visto la morte da vicino, infatti ha avuto un allievo condannato a morte, sfuggito secondo me con l’aiuto di altri allievi.
Come è arrivato a Joseph Beuys?
Joseph Beuys è un regalo della vita, dell’universo. Era amico di un amico mio che dopo essere vissuto in Germania tornò in Italia. Me lo presentò nel 1981 a Roma dove Beuys tenne un happening a sostegno di Lotta Continua, giornale per cui lavoravo, in quel momento in forte crisi (in occasione del convegno “Arte e dimensione metropolitana” a Palazzo Braschi, il 7 aprile 1981, Ndr). Dopo aver trascorso ore con la stampa mondiale mandò via tutti per poter finalmente lavorare. Me ne stavo andando quando mi disse «No, tu rimani». Rimasi soltanto io, pranzammo con tramezzini, mi raccontò tutto della sua vita, ma proprio tutto. Lo ascoltavo incantato mentre lavorava, feci anche delle foto all’opera che stava completando, in seguito acquisita dal MoMa.
Ha avuto altre frequentazioni con il mondo dell’arte contemporanea?
No, perché non mi piace, devo dire la verità. Lavorando per il giornale del lunedì di Potere Operaio ho documentato fotograficamente il lavoro che alcuni artisti realizzavano a sostegno del giornale. Serviva a dimostrare che non si trattava di falsi. Ho potuto stare accanto a loro, avrebbero voluto dare le proprie vite per l’arte ma quello che il mercato chiedeva loro era solo la merce. Un artista che all’epoca era giovanissimo e aiutava gli artisti più anziani, mi ha cercato molti anni dopo, per una grande mostra a Napoli. Voleva usare le mie foto per contestualizzare le opere di quegli anni. Mi diceva: io questa foto la vedrei larga cento metri, quest’altra alta venti... pensavo fosse impazzito. Gli diedi un pacchettino di foto, quelle venute un po’ male, con i segni dei grafici, come per dire tieni, vattene e non tornare più. Mi telefonò dopo anni per dirmi che la mostra era pronta, alla Mostra d’Oltremare che ha veramente dei padiglioni enormi e le mie foto erano davvero larghe 100 metri!
Qual è il supporto a cui è più affezionato? Il giornale, il catalogo, la mostra, dov’è che la foto trova il suo spazio ideale?
Penso sia il libro, il libro vissuto, il libro di militanza. Un vecchio compagno lo chiamava il libro d’attacco, un attacco per le anime. Ho avuto la fortuna di fare uno di questi libri d’attacco proprio sul ‘77 (È il ‘77, I libri del No, Roma, 1978, grafica di Piergiorgio Maoloni), un libro ormai scomparso che poi è stato riscoperto da Martin Parr e Gerry Badger per uno dei loro volumi sui più bei libri d’immagine (The Photobook. A History, vol. III, Phaidon, 2014). Avevano dichiarato che non ne avrebbero fatti altri dopo i primi due, poi a Paris Photo nel 2013 ne hanno annunciato un terzo e ai giornalisti che chiedevano il perchè di questo passo indietro Martin Parr ha mostrato il mio libro dicendo «Perché non avevo visto questo». È il ricordo più caro che ho, È il ‘77 mi è stato chiesto da molti musei esteri, anche dal Reina Sofia di Madrid, quello di Guernica.
Grazie a Matteo Di Castro di s.t. foto libreria galleria per la cura del portfolio delle pagine seguenti, tratto dalla mostra Bambini ribelliamoci (Castelnuovo Fotografia, giugno 2024)
(...)