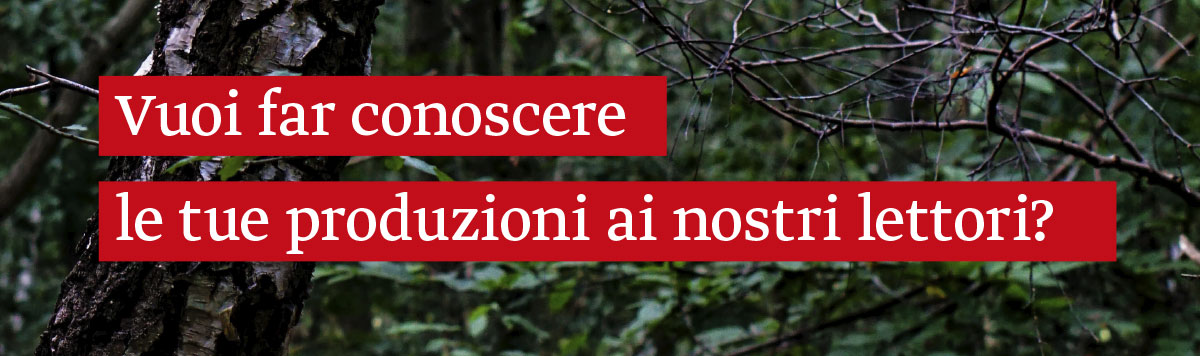POESIA. Poeta, saggista, traduttore e insegnante, quella di Milo de Angelis è una delle voci più rappresentative della nostra epoca. Qui ci racconta lo spazio della poesia, il rapporto con Milano, il lavoro di traduttore e quello di insegnante nel carcere di Opera.

Milo De Angelis in un ritratto di Dino Ignani (per gentile concessione dell'autore)
«Fin dal suo precoce e straordinario esordio, avvenuto nel 1976 con Somiglianze, la poesia di Milo De Angelis si è imposta per la sua tensione verticale, per la radicalità estrema della sua esperienza, per la capacità di esprimere il profondo disagio, il dolore dell’esserci, nei termini di una lingua e di uno stile potenti e senza artifici. Una poesia, dunque, che va al cuore delle cose e al loro mistero, che lotta con l’oscurità e la perdita di senso dell’esistere, ma che sa anche trovare improvvisi squarci di affettività e delicata sospensione». È con queste parole che l’opera di Milo De Angelis viene presentata nel volume che Mondadori ha pubblicato nel 2017 raccogliendo gran parte della sua produzione. Da allora altri titoli hanno arricchito la bibliografia di quella che viene considerata una tra le principali voci poetiche contemporanee, come Poesie dell’inizio e le traduzioni de I fiori del male di Baudelaire e De rerum natura di Lucrezio.
Abbiamo voluto iniziare la nostra intervista parlando della città in cui è nato nel 1951.
A quali luoghi di Milano è più legato?
Sicuramente i luoghi legati allo sport. Lo stadio di San Siro innanzitutto, dove ho visto tante partite del Milan dal vivo, fino a pochi anni fa. E poi tutto il quartiere di Città Studi, dove giocavo a pallone nei campetti vicini al campo Giuriati e al Parco Lambro. Quest’ultimo è anche il luogo in cui avvengono gli episodi più belli e indimenticabili di quel grande poema milanese che è L’Angel di Franco Loi. Dunque mi è doppiamente caro
Come ha visto cambiare la città nel tempo?
Nell’essenza le cose non cambiano mai e tantomeno le città. Milano è la stessa città che ho conosciuto da bambino negli anni Cinquanta, la stessa di Stendhal e Alessandro Manzoni, la stessa di Bonvesin de la Riva, che cantava le sue meraviglie nel tredicesimo secolo.
Quale spazio immagina come ideale della sua poesia, quello intimo della lettura solitaria o quello della lettura pubblica?
La lettura pubblica converge sul libro e la lettura solitaria si dilata nel mondo: due facce della stessa medaglia.
Scrivere è stare nel proprio tempo e abitare il presente o fare i conti col passato e immaginare il futuro?
Il presente di un poeta è carico di memoria e di profezia, perché nell’istante confluiscono ciò che stato e ciò che sarà.
(...)