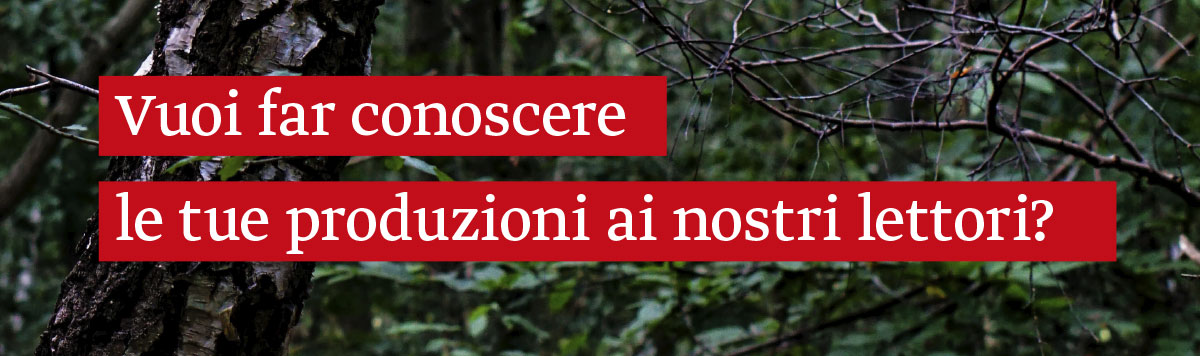Ricercatore, progettista, docente e autore, a partire dal progetto che dirige, cheFare, si occupa di come la cultura trasforma lo stato delle cose. Un rapporto che oggi richiede di “ricostruire collettivamente un discorso - e una pratica - per cui la cultura non sia quella cosuccia accessoria che fai con il tuo piccolo giro di amici ma quell’altra cosa, quella grande che è stata per millenni: un modo per fare déi, demoni, cosmogonie, rivoluzioni, insurrezioni.”

La pandemia del 2020 ha innescato tante domande sulle nostre vite e sul modo in cui ci rapportiamo allo spazio attorno a noi. Molte di esse sono ancora aperte e forse vedono più passi indietro che evoluzioni. Abbiamo visto le nostre città profondamente diverse, ad esempio, mentre restavamo in casa e sperimentavamo una diversa relazione con il lavoro e i servizi. Immaginavamo un futuro di lavoro ibrido, servizi di prossimità e nuove economie, ma oggi passi in avanti non se ne vedono e di città parliamo perlopiù per gli affitti sempre più alti e per i centri ripieni di turisti. Bertram Niessen è un ricercatore e progettista che di città, politiche pubbliche e culturali si occupa da molti anni. Ne scrive anche molto, sul sito di cheFare — agenzia per la trasformazione culturale che presiede — e su vari siti e da ultimo nel libro Abitare il vortice, in cui riflette proprio sulle trasformazioni del rapporto tra noi e le città. Lo abbiamo incontrato per interrogare il presente e per avere alcuni strumenti utili per il futuro.
Nel tuo ultimo libro “Abitare il vortice” ricostruisci la rottura del rapporto di senso tra la città e i suoi abitanti. Subito dopo la pandemia alcuni fenomeni che l’avevano contraddistinta, come lo smartworking generalizzato, stanno tornando a livelli precedenti. Contemporaneamente, le città sono tornate nel dibattito pubblico grazie alla questione dell’abitare e degli affitti. Sono sintomi di una ricostruzione del senso della città?
Stiamo iniziando a vedere dei segnali di ricostruzione, ad esempio con la nascita di un movimento nazionale attorno al Forum sociale dell’Abitare, un dispositivo di piattaforma sociale che mette assieme moltissime organizzazioni dal Terzo settore fino ai movimenti . Lì si iniziano ad elaborare politiche alternative sull’abitare, pur con una modalità di lavoro lenta dovuta all’organizzazione tramite tavoli e a numerosi incontri di avvicinamento. Localmente emergono manifestazioni molto più puntuali legate ai comitati, spesso meno strutturate e con meno riferimenti culturali, che si oppongono a questioni specifiche. C’è poi il grande movimento internazionale contro la turistificazione, che cresce ad esempio in Spagna, dove emergono le contraddizioni tra i benefici e i costi del turismo. E in generale c’è un grande fermento culturale: incontri, tavoli, pubblicazioni. Questo non basta a dare un nuovo senso della città, ma sono i prodromi per costruirlo.
Riprendo una tua citazione da un editoriale di Artribune: “Il ruolo della società civile su un territorio è come quello degli alberi su una collina: le sue radici affondano nel terreno e impediscono alle ondate del turismo di massa di straripare e trascinare via tutto “. Oltre ai movimenti di protesta cosa può fare la società civile per preservare il terreno?
Quando ragioniamo di società civile dobbiamo pensare alla possibilità di organizzare forme di relazione strutturate soprattutto per prossimità, cioè forme di cultura che hanno senso soprattutto per chi i territori li vive. In Italia solitamente questo discorso viene declinato nella poesia delle piccole cose, a metà tra Amelie e Franco Arminio, ma non significa necessariamente questo. Il mondo è pieno di modi di costruire relazioni anche attraverso esperienze culturali di rottura o provocatorie, che pensano le cose da e per gli abitanti di un territorio. Non si tratta di NIMBY e del pensare solo alle persone vicine, deve includere ponti verso altri mondi. Affinché questo accada c’è bisogno di un elemento preliminare poco discusso, cioè una consapevolezza molto forte del ruolo politico della società civile. Negli ultimi 15 anni per motivi molto diversi in Italia c’è stata un’abdicazione del ruolo politico della società civile legato al riflusso dei movimenti e alla loro perdita di potere, capacità di mobilitazione e costruzione di immaginario. Inoltre, c’è stato un progressivo e programmatico smantellamento del senso di opportunità della presenza della società civile, ad esempio nel discorso contro le ONG e la professionalizzazione, diffuso ormai anche a sinistra. C’è stato un momento in cui si è rivendicato per la società civile un ruolo esclusivamente volontaristico, rifiutando le altre forme di impegno, e questo ne ha messo in discussione le fondamenta. La società civile è inevitabilmente stratificata e complessa, unisce cose legate al volontariato e altre molto professionalizzate, e in assenza di questa stratificazione non può affrontare le sfide del contemporaneo.
Nello scorso numero con Francesca Coin abbiamo parlato di lavoro ed economia in Italia. Nella sua analisi uno dei problemi della salute del Paese è la rinuncia all’industrializzazione e politica industriale, privando le persone delle tutele derivanti da questo tipo di organizzazione del lavoro. Nei contesti urbani, principalmente post-fordisti, si può trovare un equilibrio socio-economico anche oltre l’industrializzazione?
A livello di sistema Paese sono molto d’accordo con Francesca. Sul piano urbano ci sono stati tentativi di reshoring, cercando di riportare la manifattura nelle città, ma ha funzionato solo per piccoli pezzettini. Serve adottare la lente dello sviluppo produttivo attraverso il terziario ad alto capitale cognitivo. È vero, è importante l’alto livello raggiunto dai Politecnici italiani, ma manca un mercato del lavoro per chi ne viene fuori; manca il welfare in grado di sostenere questi lavoratori. Anche le città che sono state più capaci di attirare risorse non hanno inseguito questa consapevolezza, cercando un mix tra sviluppo del mercato immobiliare finanziarizzato e turistificazione, come avvenuto ad esempio a Milano. Milano vive di un mix di capitali di origini diverse, ma non è diventata la città del lavoro cognitivo, quanto piuttosto quella del consumo di suolo e dei cantieri bloccati.
Restando su Milano, da qualche anno ne viene messo in discussione il modello di sviluppo soprattutto in termini di immaginario e narrazione della città. Guardando la dimensione più personale, tu sei diventato milanese da tempo; per te com’è si è trasformata la città?
Io sono arrivato qui 27 anni fa, prima vivendo nell’hinterland e poi in altre zone. A fine anni ’90 era evidentemente una città post-berlusconiana, molto dura e sporca, aggressiva e poco accogliente, all’opposto di Roma che sembrava sbocciare in quegli anni, ma era anche una città con una scena underground e movimenti sociali molto forti. C’era la sensazione di far parte di qualcosa, di essere uno tra decine di migliaia di persone in giro tra centri sociali. Nei primi anni Duemila c’è stato un gran fermento culturale quando Milano è stata la prima città italiana ad affacciarsi davvero su molte questioni internazionali, ad esempio quelle legate a internet e alla comunicazione, con lavori nati qui prima che altrove. Questa traiettoria è collassata con la crisi dei mutui subprime del 2007, che Milano ha vissuto peggio di altre città italiane per il legame forte con l’edilizia e la finanza. Si è consolidato un clima cupo che, assieme al riflusso dei movimenti, ha reso la città molto chiusa. Nel 2012 c’è stata una ripartenza con Pisapia e la promessa di un nuovo patto sociale. Ricordo la sera della sua vittoria, poco più che trentenne, mentre ero in piazza con gli amici punkabbestia mischiati a persone provenienti dalle start up. Si brindava tutti insieme.
L’Expo ha accelerato lo sviluppo in una direzione diversa, rendendo Milano simile a molte altre città dell’Occidente. Ora è una città molto standardizzata: c’è stato un grande evento, seguito da un forte sviluppo immobiliare, dalla gentrificazione, dalla turistificazione, e così via. Negli ultimi anni la pandemia ha colpito più duramente che altrove e ora è difficile leggerla con una nuova tridimensionalità. Continuano ad arrivare ceti molto benestanti da fuori Milano e fuori Italia, ma spesso sono persone con un sistema di valori orientato al profitto, che va in una direzione precisa. Questo si riflette sulla città. Una parte dei mondi della cultura vive una situazione di forte difficoltà sociale ed economica, e spesso l’esito è quello di lasciare la città. Mi viene in mente la metafora del dilavamento, che si collega alla citazione precedente sulle radici degli alberi: c’è un’erosione costante nella quale i flussi economici tolgono sostanze nutritive al terreno.
Vorresti restare a Milano?
Vorrei farlo se dovessero realizzarsi le condizioni per poterlo fare. Ad esempio, con la possibilità di mantenere una casa, anche in affitto ma con una certa sicurezza nel medio termine, come nella forma delle cooperative di abitanti proprietà indivisa, modello spinto anche dalle mobilitazioni recenti dei sindacati. C’è una lettera alla città di Jonathan Bazzi uscita su Domani alcuni giorni fa che va nella stessa direzione: per chi non è abbiente Milano è un posto dove restare finché non si è costretti ad andare via per problemi legati alla casa.
Nel libro racconti la rigenerazione urbana come termine ombrello con significati diversi. Se Milano ha preso una certa direzione nella sua rigenerazione, ce ne sono altre su traiettorie di sviluppo più felici in Italia?
Ci sono città che hanno traiettorie più lente come ad esempio Torino, che ha una società civile molto strutturata e una cultura meno finanziarizzata, il che la rende al momento un luogo più resiliente di Milano. Sarà molto interessante capire se i recenti vagiti di autorganizzazione e movimenti di cui parlavamo all’inizio riusciranno a produrre una nuova grande mobilitazione legata al diritto alla città e all’abitare. Se dovesse esserci una grande mobilitazione nell’immediato futuro sarà questa e passerà per la casa.
Questa è una cosa emozionante perché molti elementi sembrano aspettare solo un innesco, anche dal punto di vista culturale. Molta cultura urbana si è impigrita, mentre ci sono verdi pascoli per costruire nuovi discorsi unendo forme di attivismo e cultura partecipativa, anche radicale. Manca questo soprattutto alla sinistra storica nelle città, che si è un po’ seduta sulle conquiste del passato.
Uno degli ultimi capitoli del libro e molto lavoro di cheFare sono dedicati ai centri culturali, quei nuovi centri della cultura attorno cui si costruisce il senso delle città. Uno dei maggiori problemi è il riconoscimento di essi da parte delle istituzioni politiche e da quelle tradizionali della cultura. C’è un rapporto di fiducia rotto da entrambe le parti. A valle della Call to Action fatta nel 2020 da cheFare per indagare lo stato dei centri della cultura sono emerse 11 proposte di azione politica per supportarli. Com’è andata? Servono effettivamente a ricostruire la fiducia?
Sì, direi che negli ultimi 4-5 anni la ricostruzione della fiducia è uno dei processi che sta funzionando, perché in alcuni territori si stanno sviluppando politiche precise a supporto dei centri e si misurano già effetti positivi. Abbiamo lavorato molto con la Compagnia di San Paolo, che con la sua misura Space supporta i centri culturali e li aiuta economicamente e con apposita formazione. L’ha fatto per diversi anni di fila e sta funzionando, come ho visto in prima persona partecipando ai percorsi. Questi centri diventano più solidi, facendo quello che facevano prima ma meglio. In tutta Italia si sta sviluppando questo tema. Abbiamo lavorato con ARCI e col progetto “Essere Moltitudine” abbiamo mappato 400 dei più di 4000 circoli di tutta Italia, e sono emersi dati interessanti. C’è molto bisogno di raccontare il lavoro dei centri, e di sviluppare nuovi rapporti tra questi le istituzioni della cultura tradizionali. Dove il rapporto funziona, i legami nel territorio si stringono e lavorano meglio, rendendo i territori intessuti di connessioni di senso.
A Sud si avverte molta presenza dell’agente pubblico. Penso alla Puglia, dove molte iniziative culturali derivano direttamente da politiche regionali. In altri contesti, soprattutto a Nord, prevale la presenza di istituzioni private come le fondazioni bancarie. C’è il rischio di una scomparsa del soggetto pubblico nelle politiche culturali?
La Puglia è chiaramente un territorio con una storia recente eccezionale, anche grazie al vendolismo, e non ha omologhi in altre Regioni, se non in parte in Emilia-Romagna e Trentino che però vengono da traiettorie diversissime. Le fondazioni private di origine bancaria sono uno squilibrio gigantesco tra Nord e Sud e sono un tema complesso, perché su scala nazionale rischiano di distorcere le forme di sostegno alla cultura e al sociale. Sicuramente è meglio averle che non averle, ma sono soggetti con cui non è semplice dialogare da parte di un terzo settore frammentato. Fanno meglio del pubblico in molti casi, e questo complica ulteriormente lo scenario.
Credo che sia necessario sviluppare un discorso di politicizzazione dei soggetti della cultura e del sociale per farli dialogare in modo maturo con pubblico e privato. Negli ultimi 15 anni la dimensione politica è venuta meno e si parla essenzialmente di partecipazione ai bandi, mentre servirebbe un nuovo protagonismo dei soggetti della cultura. A Berlino, ad esempio, i soggetti della cultura dialogano costantemente con la politica locale per promuovere istanze di innovazione e trasformazione. Pur essendo una questione conflittuale non viene vissuta come rischio dalle istituzioni, ma come parte del funzionamento del sistema. Noi ci siamo disabituati a farlo.
Riprendo ancora Francesca Coin dal nostro ultimo numero, dove abbiamo parlato con lei di precariato dilagante tra i lavoratori della cultura. Una delle cause è l’aver distaccato il lavoro culturale da una concezione operaia di lavoro, cioè meritevole di tutele e paghe forti come per gli operai di fabbrica. Manca, cioè, un certo grado di sindacalizzazione. Alcuni numeri fa sempre su Awand Ivan Carozzi, peraltro autore per cheFare, parlava di neurosostenibilità del lavoro culturale e necessità per il lavoratore di darsi una giusta postura, cioè un distacco tra quel che fa per mantenersi e la passione verso quel che fa, al fine di preservare la sua salute e di chiedere giuste paghe. Credi siano questi i problemi del lavoro culturale?
Sono molto d’accordo con entrambi. Con Ivan avevamo pensato di riprendere e allargare il tema della neurosostenibilità su cheFare in forma di macroinchiesta. Forse aggiungerei un altro tassello a questa prospettiva. Nel prossimo numero de laRivista di cheFare ci chiederemo “a cosa serve la cultura?”. Io sono del ’79 e faccio parte della prima generazione precarizzata che non ha mai avuto - o ha avuto troppo tardi - il lavoro a tempo indeterminato. Il tassello mancante è quello del consumo di cultura, che in Italia ha spesso forme poco sfidanti nei confronti della collettività e dell’individualità. Prevale il “camerettismo”, cioè il consumo culturale da camera rivolto alle abitudini individuali e ai piccoli cerchi intimi, mentre servirebbe un approccio più d’arrembaggio in grado di togliere la dimensione consolatoria del piccolo consumo culturale. Invece di pescare continuamente da cose sperimentate durante l’adolescenza, dovremmo scavare nelle contraddizioni del contemporaneo per far saltare il banco. Questo approccio alla produzione e ai consumi si integra - credo - con i discorsi di Francesca e Ivan.
Nel dibattito pubblico e settoriale sembra assopito il tema della sostenibilità economica delle attività culturali. Il modello ibrido tra la capacità di vincere bandi e quella di far pagare un giusto biglietto sembra essere quello consolidato, forse a scapito della libera progettazione o dell’ampia partecipazione. È questo il punto di arrivo della sostenibilità economica?
È vero, il discorso sulla sostenibilità economica della cultura è appiattito su poche posizioni ipersemplificate. Da un lato quelle della messa a reddito: “per ogni euro investito in cultura nel territorio ne tornano x”, “è il nostro petrolio”, “serve per lo sviluppo del turismo”, etc. Dall’ altra, le posizioni del valore a tutti i costi: “ogni singolo sasso, dipinto, intonaco sparso tra città e campagne ha valore in quanto tale”. Sono posizioni che servono a sterili contrapposizioni e a politiche miopi, perché dimenticano alcune cose fondamentali. Innanzitutto, che la cultura “serve” prima di tutto a costruire libertà, soggettivazione e capacitazione individuale e collettiva. E che quindi i suoi costi vanno misurati sulla base degli impatti di trasformazione del reale, diretti e indiretti, che può generare.
In secondo luogo, come dicevo prima è necessario uscire dal giogo delle nicchie: le camerette dove riascoltare le canzoni dell’ adolescenza, i circolini in cui ci si scambiano perle nascoste, le microbolle in cui coltivare velleità e stoccare piccole quantità di capitale culturale. Per ragionare sulla sostenibilità economica della cultura negli anni 20, di fronte a sfide radicali bisogna interrogarsi sulle forme possibili di immaginari radicali di massa: come pensarli, come costruirli, come distribuirli.
Entrando in uno specifico settore, un recente articolo de il Post a firma di Gabriele Niola ha riacceso la discussione sul numero eccessivo di film prodotti in Italia, la maggior parte dei quali ha un ritorno economico, e probabilmente un valore culturale, nullo o quasi. Le maglie larghe dei finanziamenti pubblici, peraltro in riduzione col ministro Sangiuliano, da un lato promettono di mantenere il cinema indipendente, dall’altro lato “drogano” il mercato producendo più di quanto non possa essere distribuito o visto. In questi casi è giusto tagliare i fondi o vanno trasformate le modalità di distribuzione delle risorse?
Tagliare i fondi alla cultura è sempre sbagliato, è sempre una sconfitta. Ha senso però ragionare su sistemi di distribuzione nuovi che superino quello che nell’ articolo di Niola vengono definiti “i giri delle feste di compleanno”, film visti solo dagli amici della troupe. Ci sono molti esempi di partecipazione culturale comunitaria o diffusa al cinema contemporaneo. Con mille diversità, penso al Beltrade o al Cinemino a Milano, al Cinema America a Roma, al Cinema Ritrovato a Bologna. Sono strade su cui si può investire in modo strutturale per moltiplicare luoghi e tipologie di visione.
Nelle ultime elezioni europee la cultura è stato un tema ombra nonostante l’enorme impatto di risorse e politiche europee sui progetti culturali. Cosa potremmo fare per riaccendere il dibattito su questo?
Credo che sia necessario guardare soprattutto al posizionamento politico di produzione, distribuzione e consumo di cultura come “costruzione di mondi”. Ricostruire cioè collettivamente un discorso - e una pratica - per cui la cultura non sia quella cosuccia accessoria che fai con il tuo piccolo giro di amici ma quell’ altra cosa, quella grande che è stata per millenni: un modo per fare dèi, demoni, cosmogonie, rivoluzioni, insurrezioni. Portare al centro del discorso culturale - in altri termini - sia l’incantamento che la politica. O forse un incantamento politico.

(...)